dir: Riccardo Chailly (1983)
(dal film diretto da Jean-Pierre Ponnelle)
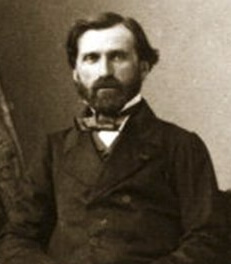 Il breve preludio dell'opera appare oscuro e tenebroso, con un incedere funebre, in forte contrasto con le prime scene che immediatamente seguiranno (la festa a Palazzo Ducale) e che saranno invece vivaci e leggere. La cupezza del preludio è naturalmente un'anticipazione del dramma che verrà, con tutto il suo bagaglio di cospirazione, di inganno e di dolore, e la tragedia è annunciata dal tema musicale della maledizione. Ricordiamo che proprio "La maledizione" (o "La maledizione di Saint-Vallier", quando ancora si sperava di poter usare i nomi originali del dramma di Victor Hugo) avrebbe dovuto essere il titolo dell'opera. Fra le molte richieste dei censori austriaci, ci fu quella di cambiarne il nome, forse perché metteva troppo in risalto un concetto ritenuto blasfemo. Verdi, pur accettando di reintitolare l'opera con il nome del protagonista, era però ben conscio della sua importanza tematica. In una lettera al librettista Piave, il compositore scriveva:
Il breve preludio dell'opera appare oscuro e tenebroso, con un incedere funebre, in forte contrasto con le prime scene che immediatamente seguiranno (la festa a Palazzo Ducale) e che saranno invece vivaci e leggere. La cupezza del preludio è naturalmente un'anticipazione del dramma che verrà, con tutto il suo bagaglio di cospirazione, di inganno e di dolore, e la tragedia è annunciata dal tema musicale della maledizione. Ricordiamo che proprio "La maledizione" (o "La maledizione di Saint-Vallier", quando ancora si sperava di poter usare i nomi originali del dramma di Victor Hugo) avrebbe dovuto essere il titolo dell'opera. Fra le molte richieste dei censori austriaci, ci fu quella di cambiarne il nome, forse perché metteva troppo in risalto un concetto ritenuto blasfemo. Verdi, pur accettando di reintitolare l'opera con il nome del protagonista, era però ben conscio della sua importanza tematica. In una lettera al librettista Piave, il compositore scriveva:
Tutto il sogetto è in quella maledizione che diventa anche morale. Un infelice padre che piange l’onore tolto alla sua figlia, deriso da un buffone di corte che il padre maledice, e questa maledizione coglie in una maniera spaventosa il buffone, mi sembra morale e grande al sommo grande.Tolta dal titolo dell'opera, la maledizione si ritaglia un enorme spazio nella musica. Oltre a ricorrere più volte nel testo del libretto con grande enfasi (si pensi ai finali dell'Atto I e soprattutto dell'Atto III, "Ah! la maledizione!", proprio sulla calata del sipario), Verdi le dedicò un'attenzione particolare nella partitura, tessendo un vero e proprio "arco semantico" in do, a partire ovviamente dal preludio (i cui accordi risuoneranno altre volte nel corso dell'opera). Non era una novità per lui: già in "Ernani" aveva basato il preludio sul motivo fondamentale del dramma. Qui, però, l'effetto è ben più maggiore e duraturo, giungendo a scuotere lo spettatore nel profondo e facendolo partecipare come non mai alla tragedia, ancora prima che questa cominci (che cos'è in fondo una maledizione, se non un preavviso di una tragedia che incombe? E cos'è un'ouverture o un preludio di un'opera, se non un preavviso dello stesso tipo?). Si può dire che Verdi compose come se il titolo non fosse mai stato cambiato, sconfiggendo in questo la censura, interessata a intervenire sulle parole ma non sulle note.
[Il preludio] è un puro gesto sonoro che prepara magistralmente lo sviluppo dell’intero dramma: Monterone romperà l’allegria della festa intonando la stessa nota (Do) per scagliare la sua invettiva contro il Duca che gli ha sedotto la figlia, e contro il buffone che gli rifà il verso per schernirlo. La sequenza iniziale viene poi connotata nella scena successiva, quando Rigoletto ripensa a quelle parole rientrando a casa, e sosta declamando «Quel vecchio maledivami!». (...) Il preludio è dunque l’argomento di una tragedia incanalata su un percorso obbligato. (...) Grazie al reticolo musicale creato dal motto della maledizione, nelle sue implicazioni metriche e armoniche, Verdi scavalcò di slancio ogni censura ponendo in enfasi il concetto che stava alla base del suo dramma, o fu forse il divieto a stimolarne vieppiù l’estro. Ne scaturì una delle sue tragedie più immani, che corre rapida coerente ed implacabile verso la catastrofe, pervasa di un disperato rigore morale.(Michele Girardi)
Melodicamente il motivo è vago, amorfo, con struttura irregolare di tre battute e contorni melodici appena abbozzati. Il suo potenziale energetico è concentrato nel ritmo doppiamente puntato di tromba e trombone, che in nove battute di crescendo conduce all’esplosione di un fortissimo, dissolto poi in una catena di figure singhiozzanti di violini e legni. Ricompare un breve richiamo al motivo principale, modellato per due volte in schema di cadenza; quindi una coda di sei battute, con i sordi rintocchi di un incisivo “a solo” di timpani, conduce alla veemente cadenza finale.(Julian Budden)
dir: Francesco Molinari-Pradelli (1967) | dir: Richard Bonynge (1971) |
Il preludio in una scena del film "Maledetti vi amerò" (1980) di Marco Tullio Giordana





0 commenti:
Posta un commento